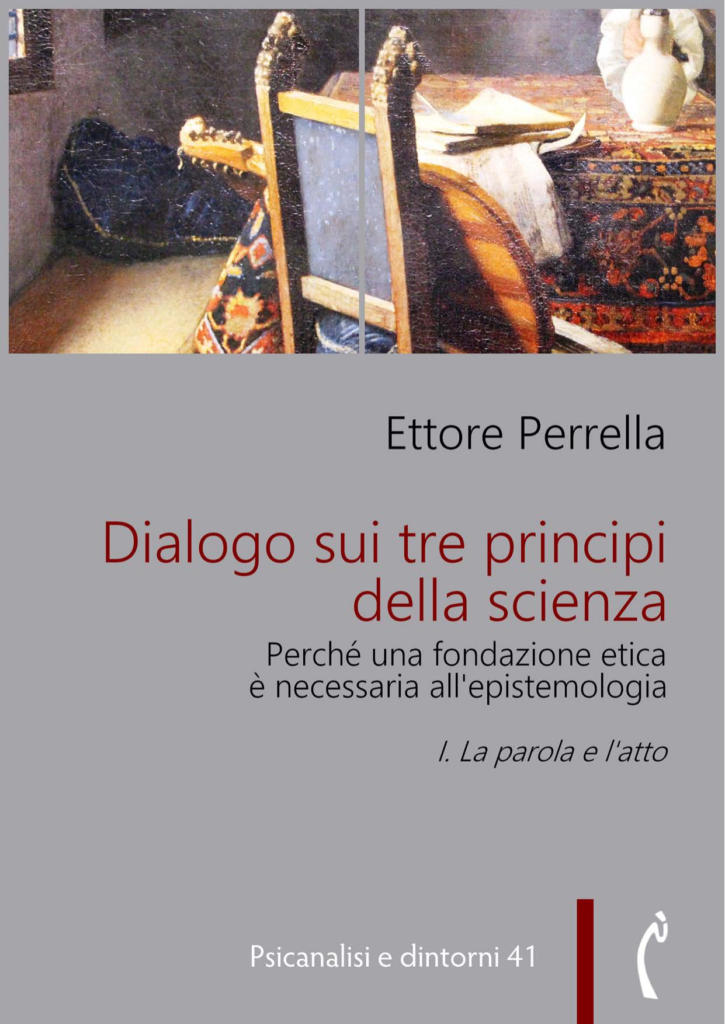Un Deus absconditus
Nella breve presentazione del mio libro Il cinema di Rohmer. Un approccio spirituale[1] che appare su quella che nel gergo editoriale viene detta “quarta di copertina” si parla del mio pormi anche in questo caso sulle orme del Trascendente e alla ricerca delle “tracce dell’Assente”. Non è un caso se le parole Trascendente e Assente siano scritte con la lettera maiuscola. La mia ricerca infatti va oltre una indagine di tipo filosofico o esistenziale ma pur muovendo da lì i suoi passi ha scelto poi di accedere ad un livello teologico e spirituale del discorso in cui ad essere interrogato è il Dio della tradizione biblica anche se ciò può essere meno evidente e solo sottinteso nel caso del libro sul cinema di Yasujiro Ozu (1903-1963)[2]. San Giovanni della Croce, il grande mistico spagnolo del sedicesimo secolo affermava che dal momento in cui il Padre ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta in questa sola Parola e non ha più nulla da dire. Si tratta di un concetto che è presente nel Nuovo Testamento nella lettera agli Ebrei e in altri testi soprattutto giovannei e paolini. Il Dio che ha scelto di rivelarsi in maniera totale e definitiva nel suo Figlio Gesù Cristo (Eb. 1,2) non cessa tuttavia di essere un Deus absconditus[3], un Dio nascoso, che spesso a noi sembra essere avvolto e occultato da una coltre di silenzio e di “assenza”. Da qui quell’esigenza inestinguibile e quell’inquietudine che ci portano a cercarlo senza sosta “andando come a tentoni” (At. 17,27) e a volte non senza affanno come la sposa del Cantico dei cantici cerca l’Amato. Anche solo un segno del suo passaggio, un’orma o una traccia della sua silenziosa e invisibile presenza colmano il nostro cuore di una gioia sublime e indicibile (1Pt. 1,8) ed è per questo che il desiderio che anima la nostra ricerca lungi dall’ estinguersi si riaccende e si accresce man mano che intravediamo qualcuno dei suoi segni.
Lo stile di Ozu
Ora l’espressione “le tracce dell’assente” in questo caso scritto con la minuscola non è del tutto mia, in quanto l’ho trovata in un testo[4] che cito più volte nel mio libro dedicato al regista giapponese. Il libro di Carlos Martìs Arìs è dedicato ad alcune figure eminenti di artisti del ventesimo secolo nelle cui opere risulta determinante il tema del silenzio che squarcia il tetto dell’immanenza. Tra loro l’autore inserisce anche Yasujiro Ozu a cui dedica un capitolo, il quinto: “Ozu o le tracce dell’assente”[5]. Si tratta di un brano testuale ricco di spunti metafisici che cerca di penetrare nel significato di una poetica che ha radici profonde spingendosi oltre la realtà fenomenica e aprendosi sul mistero della trascendenza. Io ho scelto di fare mia l’espressione per certi versi misteriosa ed enigmatica “tracce dell’assente” subendone il fascino affatto particolare, dando tuttavia alle parole, man mano che mi dedicavo ai saggi su Bergman e Rohmer, un senso più compiuto e definito che trova il suo contesto vitale di riferimento nell’ambito della rivelazione biblica e cristiana in particolare. Trovo tuttavia di considerevole importanza e significato che tali tracce si possano rinvenire anche nel percorso personale di un grande autore che appartiene ad un mondo culturale che per molti aspetti ci risulta estraneo.

Il regista nipponico ha tratto dall’humus della propria tradizione culturale e religiosa i valori spirituali che informano la sua arte che quasi non è comprensibile se si prescinde dalla comprensione del loro apporto. Concetti come“mu”[6], “mono no aware”[7], “omiai”[8], “ie”[9], “devozione filiale”[10] sottendono il pensiero del regista e la sua precomprensione della realtà ispirandone profondamente lo stile. Egli adotta di fatto un punto di vista “obliquo”, ponendosi come di lato, senza che la sua persona sia al centro e si frapponga tra l’obiettivo e la realtà, il suo non è solo un osservare ma anche un mettersi in ascolto, un ascolto che si fa umile e rispettoso. È da tale postura che gli oggetti e le persone stesse vengono inquadrati dalla macchina da presa, quasi attendendo il momento in cui vivranno un mutamento e una trasformazione che solo a volte si rende più percepibile. È a quel momento che lui tiene particolarmente ed è in tal modo che “l’inventario del quotidiano si trasforma dunque in una invocazione spirituale”[11]. La società e la famiglia che ne rappresenta il distillato e anche il microcosmo sono lette attraverso questa lente e il tempo è il fattore saliente attraverso cui tutto viene filtrato. Nel testo ci sono riflessioni molto dense sullo stile peculiare di Ozu e anche sul significato dei suoi celebri “piani vuoti”, quegli inserti nel flusso narrativo che lo interrompono per qualche secondo. Essi sono abitati da un silenzio che a volte si fa ricettacolo di emozioni e stati d’animo e altre ne diventa evocatore attraverso oggetti inanimati o ambienti spesso domestici svuotati della presenza umana. Per spiegare meglio ciò che l’autore intende per “tracce dell’assente” nel capitolo si fa una breve analisi di alcuni brani tratti dalle opere del regista giapponese. Voglio soffermarmi su di uno in particolare riguardante le sequenze finali di Viaggio a Tokyo (Tokyo Monogatari, 1953). Vi sono rappresentati tre personaggi del film mentre sono soli e pensano.

Le sequenze finali di Viaggio a Tokyo
La storia volge al termine e il vecchio Sukichi che ha perso da poco la compagnia della moglie Tomi è nella sua casa, seduto sul tatami in silenzio davanti alla finestra, lì dove prima amava sedere insieme con lei. Caccia una mosca fastidiosa che gli vola vicino al viso e guarda al di fuori verso il porto di Onomichi e il mare. Tra poco si affaccerà la vicina e la saluterà sorridendole gentilmente come è suo modo. Gesti consueti che si ripetono e fanno pensare a quando con lui c’era Tomi, i gesti sono gli stessi ma allo stesso tempo sono mutati, hanno un sapore diverso. Rimane sospeso nell’aria il non detto, l’implicito, tutti lo pensiamo guardando questa scena e non sono tanto le parole a manifestarlo, ancora nessuno ha parlato, ne altri elementi che vi siano presenti, a rivelarlo sono le tracce dell’assente[12].
Poi c’è Kioko, la figlia di Sukichi che è maestra e mentre i bambini cantano lei si affaccia alla finestra dell’aula e guardando l’orizzonte pensa. Sa che tra poco vedrà passare il treno per Tokyo su cui è appena salita la cognata Noriko, quel treno le evoca tutto un passato recente fatto di parole ed emozioni, di lutti e amarezze, di scoperte e rivelazioni: nulla sarà più come prima. La figura del treno come è in grado di presentificare una realtà interiore così nella sua corsa porta lontano. Il protagonista è il silenzio e a parlare sono solo le immagini e in sottofondo il coro dei bambini ma le tracce di ciò che è stato (e di un turbamento verso un futuro inconoscibile) si fanno segno e memoria e pur essendo a tutti gli effetti invisibili e impalpabili vengono impercettibilmente trasferite dalla composizione di quella scena con al centro la figura pensosa di Kioko, direttamente al cuore dello spettatore.
L’altro vertice di questo triangolo ideale è rappresentato da Noriko che su quel treno sta lasciando la casa dei suoceri e del marito disperso in guerra per tornare a Tokyo, la città dove lei vive e lavora e che indica il suo futuro. Il treno è immagine del tempo che trascorrendo si lascia dietro paesaggi, città, campagne, in una parola il passato. E insieme alla dimensione temporale «introduce la dolorosa coscienza che tutto si avvia irreversibilmente alla fine». Noriko osserva l’orologio da taschino che le ha regalato il suocero (ancora un rimando al trascorrere del tempo), era quello che apparteneva alla moglie defunta, non può che commuoversi e piangere pensando a quel dono, all’affetto ricambiato verso Tomi, alla propria travagliata storia matrimoniale, una storia che non vuole lasciarla e che neppure lei vorrebbe lasciare. Ma le parole di Sukichi hanno sollevato il suo animo da scrupoli insensati, un tempo sta davvero esaurendo il suo corso… Nel silenzio di uno scompartimento ferroviario l’unico rumore che si avverte è lo stridore meccanico e sordo del treno sulle rotaie. Silenzio imperfetto “in cui si imprimono le tracce dell’assente” [13].
[1] Bersan D., Il cinema di Rohmer. Un approccio spirituale, Polimnia Digital Editions, Sacile (PN) 2024.
[2] Bersan D., Figure del padre in Ozu, Polimnia Digital Editions, Sacile (PN) 2020.
[3] Is. 45,15. Rimando anche alle mie riflessioni a commento del film “Luci d’inverno”: Bersan D., Dio ridotto al silenzio. Pensieri inattuali su Bergman, Polimnia Digital Editions. Sacile (PN) 2021, pag. 149-153.
[4] Martìs Arìs C., Silenzi eloquenti. Borges, Mies van der Rohe, Ozu, Rothko, Oteiza, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2002.
[5] Op. cit., pag. 58-69.
[6] Concetto buddista che richiama al vuoto, al nulla inteso non nel senso nichilistico proprio dell’Occidente ma come feconda matrice in cui l’io si perde per poi ritrovarsi in un processo di perenne movimento attraverso l’estinzione e la rinascita.
[7]Dolce mestizia che prende l’animo mentre contempla il dileguarsi inarrestabile delle realtà umane.
[8] Si tratta del matrimonio combinato dalle famiglie dei futuri sposi, anche attraverso un mediatore interno o esterno alla famiglia.
[9] È la famiglia tradizionale giapponese che ospitava più generazioni e anche altri membri adottati o acquisiti.
[10] È uno dei principi cardine della dottrina confuciana.
[11]Op. cit. pag. 63.
[12] Op. cit. pag. 67.
[13] Op. cit. pag. 67. La citazione si riferisce alle parole che nel testo commentano un altro film di Ozu, “Inizio di primavera” (Soshun, 1956) e riguardano la scena finale in cui i due coniugi momentaneamente riconciliati e lontani da Tokyo, la loro città, osservano in silenzio il treno che lentamente si allontana attraversando quel grigio paesaggio industriale.